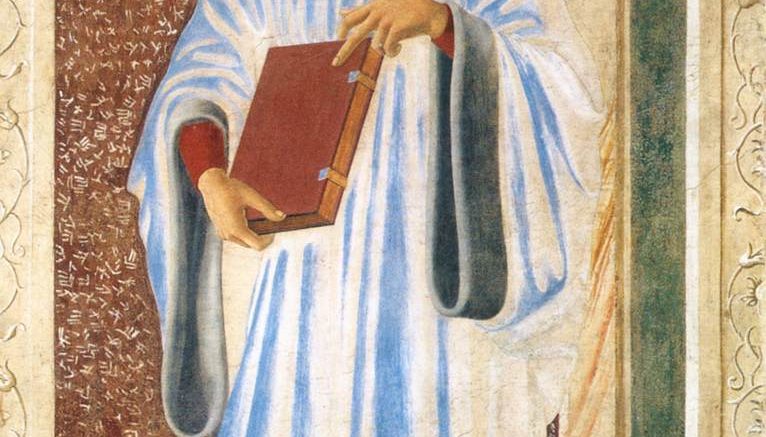La vita.
Figlio di un ricco mercante fiorentino, nasce a Firenze o a Certaldo nel 1313. Si rivela uomo di lettere più che d’affari. Dal 1327 al 1340 è a Napoli. Il padre lavora come rappresentante dei Bardi, banchieri degli Angioini. Racconterà, Giovanni, della sua intensa vita mondana nel Filocolo e nel Decameron. A Napoli incontra Cino da Pistoia, i giuristi Barbato da Sulmona e Pietro Barilli, il frate agostiniano Dionigi da Borgo Sansepolcro. Da costoro conosce l’opera di Petrarca che incontrerà in seguito a Firenze. Nella biblioteca angioina viene in contatto con opere importanti. Tra il 1340 e il 1341 rientra a Firenze. Fa intensa attività culturale, scrive una biografia di Petrarca, studia la vita e le opere di Dante. Scrive su Dante una biografia informatissima interrogando pure coloro che lo avevano conosciuto (Trattatello in laude di Dante, 1351-55). Commenta la Commedia nelle incompiute Esposizioni. Copia di sua mano in un codice la Vita Nova, la Commedia e 15 canzoni dantesche anteponendovi il Trattatello. Nel 1360 prende gli ordini sacri. Muore a Certaldo nel 1375.
Opere anteriori al Decameron.
A Napoli lavora al Filocolo, al Filostrato, al Teseida, tutte in volgare. Sono opere che mescolano il poema epico e l’elegia amorosa. Filocolo (fatica d’amore secondo l’erronea etimologia pensata dall’autore) è un romanzo con la storia di un amore contrastato fra i giovani Florio e Biancifiore. Il romanzo è il contenitore per diversi generi letterari: dall’epistola alla novella, dalla questio alle dissertazioni dottrinali. Il romanzo, nella parte che collauda il motivo della brigata di giovani riuntiti a raccontare novelle, è propedeutico alla trama del Decameron.
Il Filostrato è ispirato alla Historia destructionis Troiae di Guido delle Colonne. È un poema in ottave che narra la storia d’amore di Troiolo (Troilo) e Criseide sullo sfondo della guerra di Troia. (Secondo una approssimativa etimologia greca Filostrato significherebbe “vinto d’amore”. Parla delle gesta di Teseo (oscuro episodio della mitologia greca). Il modello ispiratore non sono qui Virgilio e Stazio, ma Ovidio. Negli anni successivi al rientro a Firenze lavora a due opere legate alla tradizione e alla vita fiorentina: la Comedia delle ninfe fiorentine e l’Amorosa visione. La prima è un prosimetro (chiamata anche Ameto) che narra di come il pastore Ameto incontrate alcune ninfe nel bosco si sia fermato ad ascoltare il canto di una di loro, Lia, innamorandosene. Anche Ameto poi diviene cantore ingentilendosi anch’egli, allegoria che intende il passaggio dell’umanità dalla barbarie alla civiltà.
L’Amorosa visione è un poema in terzine di ispirazione dantesca, ma di difficile lettura. Offre tuttavia un modello di allegoria laico-umanistica alternativo o complementare a quello proposto da Dante nella Commedia.
L’Elegia di madonna Fiammetta fa a meno della allegoria e ci offre, in monologo, una specie di romanzo psicologico o confessione.
Abbiamo il poema in ottave Ninfale fiesolano che ritorna alle forme e ambientazioni dell’Ameto. Il pastore Africo ama la ninfa Mensola, ma il loro amore è vietato da Diana. Africo si uccide e Mensola viene trasformata nelle acque di un fiume. Il figlio nato da loro, Pruneo, sarà tra i fondatori di Fiesole e da lui trarrà origine una delle più nobili genti fiorentine.
Il Decameron.
Ovvero “dieci giornate” è degli anni successivi alla peste vera del 1348. Composto di 100 novelle. Il libro viene ultimato forse nel 1353. Nel ventennio successivo l’autore continuerà a ritoccarlo. La sua ultima volontà è consegnata a un manoscritto autografo databile al 1370, cinque anni prima di morire. La trama è semplice; nel 1348 la peste imperversa a Firenze. È possibile che Boccaccio abbia presente qui dei modelli letterari o figurativi. Il tema della peste è già stato trattato da Tucidide, Lucrezio e Paolo Diacono, così poi in Manzoni e Camus. Egli comunque fu testimone diretto del flagello. Sette donne e tre uomini abbandonano la città per evitare il contagio. Due settimane di esilio volontario. L’artificio narrativo che permette di saldare insieme le novelle non è un’invenzione di Boccaccio, è già nota alla tradizione narrativa indiana e araba (Mille e una notte) o anche la Disciplina clericalis dell’ebreo spagnolo Pietro Alfonso, una serie di racconti che un padre raccoglie allo scopo di istruire il figlio. Ma mentre nelle raccolte pre-boccacciane la cornice è un semplice artificio, in Boccaccio la cornice ha un ruolo più importante e una ben maggiore estensione. Non è lo sfondo, ma il vero motore narrativo dell’opera, ovvero il macrotesto che organizza e regola tutte le singole novelle. Amore e fortuna sono i temi dominanti del libro. Dell’amore nel Decameron è prevalente la dimensione burlesca o euforica. La fortuna ha il senso di caso, destino, fatalità, accidente, peripezia. All’amore e alla fortuna si devono aggiungere la beffa e il motto. Il lascito più duraturo del Decameron è nella rappresentazione della vita così com’è. L’opera ha più stili che si adeguano alla varietà dei registri inscenati dalle novelle.
La prosa di Boccaccio è elaborata, sintatticamente complessa, talvolta sigillante i periodi con particolari figure ritmiche. Boccaccio è maestro del discorso diretto, diversamente dai predecessori, con caratterizzazione individuale. È anticipatore della polifonia di linguaggi tipica del romanzo moderno. Qui la figura fonica è l’omoteleuto (l’identità di desinenza tra parole contigue in un testo in prosa). Molti sono pure i modelli. Alcuni possono essere i Saturnalia di Macrobio o le Metamorfosi di Apuleio. Una fonte figurativa è stata segnalata negli affreschi raffiguranti il Trionfo della morte nel Camposanto monumentale di Pisa. Inoltre, gli “esempi” in latino (la Leggenda aurea di Iacopo da Varazze); le poesie e favole francesi (fabliaux) lette alla corte degli Angiò; le commedie mediolatine; i classici della letteratura italiana; il Novellino; la Commedia; i proverbi e gli aneddoti circolanti a Firenze.
4.Opere posteriori al Decameron.
Dopo il Decameron Boccaccio abbandona le “favole romanzesche e le proprie poesie in volgare. Si impegna in alcuni trattati eruditi in latino. Il re di Cipro, Ugo IV di Lusignano gli aveva sollecitato un libro sulla mitologia classica. Vi lavorò, componendo le Genealogiae deorum gentilum. È un’opera in 15 libri. Egli ultimi 2 libri si profonde in un’appassionata difesa della poesia, indirizzata – come la filosofia e la teologia – al progresso delle conoscenze e al miglioramento dei costumi, al contrario del diritto e della medicina indirizzati al guadagno. All’obiezione, mossa alla poesia, di consistere solo in ‘favole’ e ‘storie inventate’ risponde dicendo che la vera scienza consiste nel saper vedere sotto il velo dell’allegoria, il contenuto di verità. Il De cosibus virorum illustrium (1360) e il De mulieribus claris (1361) sono 2 opere di carattere moralistico-erudito. Lo stile qui è diverso: il piacere del raccontare del Decameron è abbandonato. Si tratta qui di esempi illustrati moralisticamente. Nel Corbaccio, databile al 1365, è un testo misogino che s’inserisce nella tipica produzione dell’epoca. È quasi un controcanto al De mulieribus claris.
La fortuna.
Il Decameron godette di grande successo quando l’autore era ancora in vita. Fu libro popolare, pure oggetto di riscritture ed ebbe grande successo all’estero. Piacque anche a Petrarca che tradusse in latino la novella Griselda. La ripresa ‘interesse verso l’opera ha luogo prima all’interno del circolo di Lorenzo il Magnifico e di Poliziano, poi con Pietro Bembo che indica nel volgare usato da Boccaccio un modello da seguire. Ciò prelude al grande successo cinquecentesco del libro ristampato in 70 edizioni nel solo XVI secolo e imitato da generazioni di narratori. Dopo un periodo di disinteresse la fortuna si apre di nuovo nell’Ottocento, soprattutto per merito di Francesco De Sanctis che vi ravvisa il caposaldo del Realismo moderno. Di Boccaccio, che diviene una sorta di anti-Dante, vede lo spirito terreno e laico. De Sanctis lo considera non come una collezione di novelle, ma libro compatto.