di Sergio Mauri
Parlare di precarietà significa parlare della storia del capitalismo che, nel continuo rivoluzionamento del proprio sistema produttivo e delle conseguenze sociali che provoca, ha la sua ragione sociale. La precarietà è insita nel nostro sistema che, con un eufemismo, chiamiamo “di mercato”. La nostra non è una società armoniosa o che ricerchi la vera mediazione degli interessi, cominciando col dare a tutti pari opportunità di partenza, ma è una società fondata sulla competizione e sulla guerra, per nulla solidale, basata, al contrario, sulla sopraffazione. La mediazione è necessaria proprio per limare queste questioni.
La precarietà è fatta di basso reddito, insicurezza lavorativa, sfruttamento, degrado abitativo, della sanità, scolastico, di drenaggio di risorse da chi non ha, o poco ha, a chi ha molto. La precarietà è una condizione generale della nostra epoca ed è una condizione globale. Cioè riguarda tutti. Sospetto che ormai sia anche una condizione mentale, connaturata al declino dell’Occidente che spero sia definitivo quando l’Occidente è predatore e imperialista, ma reversibile quando parliamo della nostra grande cultura e storia dell’emancipazione sociale.
La precarietà riguarda noi che viviamo tutti questi limiti economici e politici, nonché mentali, ma riguarda anche quegli esseri umani che noi chiamiamo immigrati, nostri fratelli e sorelle, che si devono spostare dai propri paesi per sfuggire a condizioni ancor più precarie delle nostre, condizioni al limite, tra la morte per fame o per guerra e le persecuzioni. Situazioni spesso create o aiutate dal “nostro mondo libero”.
La questione della precarietà è tutta interna alle compatibilità del sistema che è capitalistico. Un sistema fondato sullo sfruttamento e, proprio per questo, alla ricerca di condizioni sempre migliori per produrre a basso costo e vendere i suoi prodotti con margini di profitto sostenibili per quella classe di possessori di mezzi di produzione e mezzi finanziari, che poi sono le stesse persone. E’ una classe molto limitata a livello planetario, ma non così esigua. La possiamo quantificare in alcuni milioni di persone, otto o nove.
Allora o si esce dal sistema perché si è capito che non porta null’altro che sfruttamento e distruzione oppure lo si tiene per quello che è, sapendo, comunque che non porterà la fine della precarietà, ma al suo allargamento. Se non vogliamo uscirne, se non vogliamo rischiare nulla, allora permettetemi di porvi una semplice domanda. Siamo disposti, tutti noi, a pagare 20 € un chilo di pane, un paio di scarpe Nike 500 € o una t-shirt 150? Eh si, perché solo così potremmo far riaprire le nostre fabbriche che non avrebbero bisogno di “migrare” alla ricerca di bassi salari per competere sempre di più. Gli immigrati non ci sarebbero, rimarrebbero a casa loro perché pagheremmo il giusto prezzo per le produzioni dei paesi svantaggiati che di produzioni a dire il vero poche ne hanno: magari un chilo di mele o di noci dal Cile lo potremmo pagare 10 €. Magari il pellame dal Senegal lo pagheremmo molto di più di ciò che facciamo oggi, anche se la qualità fosse bassa (come spesso è) finanziando l’apertura vera (non finta come facciamo sempre) di concerie, e quindi fabbriche di scarpe, eccetera.
Allora, ripeto la domanda: siamo disposti a farlo? E possiamo farlo? Questo per ciò che riguarda noi, i cosiddetti cittadini-consumatori. E dal lato delle imprese: sono queste disposte a pagare il triplo o il quadruplo per battere la precarietà che è anche sottosviluppo? E lo Stato, è disposto a far funzionare i propri servizi rendendo meno precaria, appunto, la vita di tutti noi?
Tuttavia, l’idea che noi abbiamo di una società diversa non ha nulla a che fare con la semplice piena occupazione (irraggiungibile) o con soldi facili (impossibili) per tutti con i quali comprare degli inutili beni di consumo. La nostra idea di società si fonda sul disporre tutti dei beni necessari per vivere, sul lavoro necessario a riprodurre la società suddiviso tra tutti i suoi membri in modo egualitario, sulla solidarietà attiva, sul rispetto dell’ambiente per la cui realizzazione la prima cosa da fare è porre fine alla schiavitù del profitto.

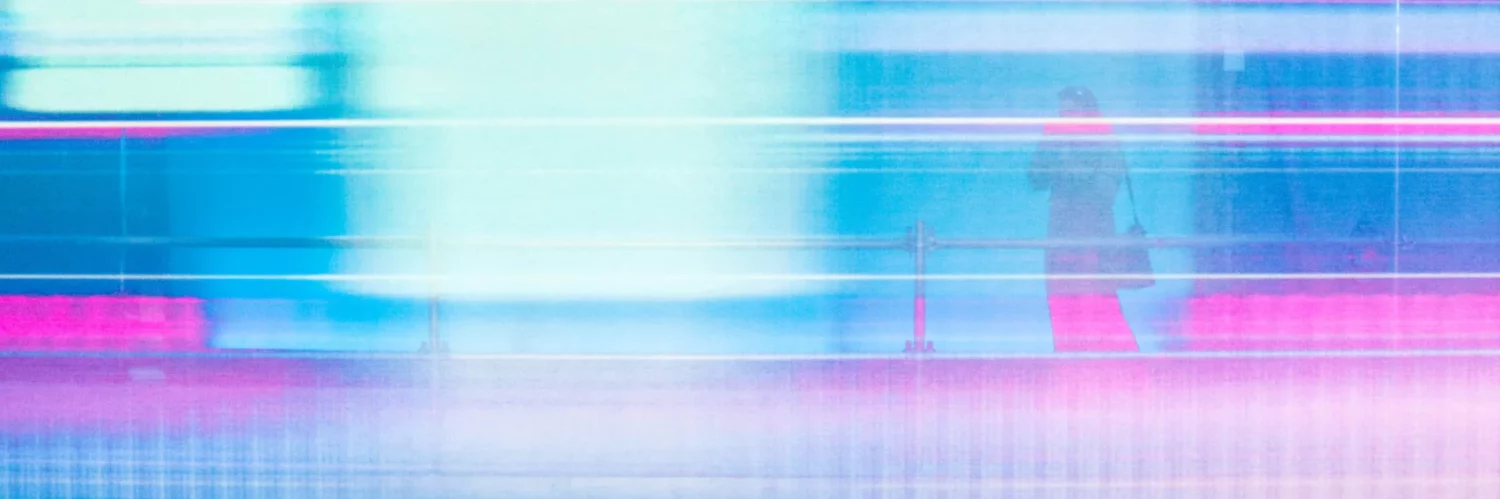

Be the first to comment on "Il precariato."