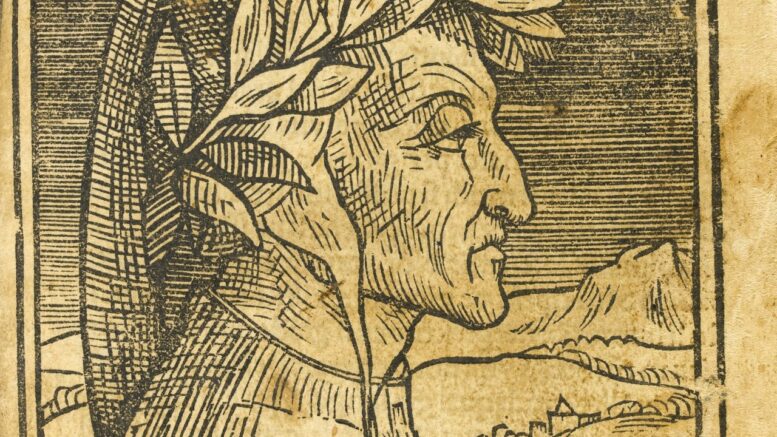Nel I capitolo del trattato, Dante pone la definizione dell’allegoria e la netta partizione in allegoria dei poeti e allegoria dei teologi. Egli usa l’allegoria dei poeti. Abbiamo quindi la narrazione di un fatto, di una storia non accaduti in quel modo, una narrazione menzognera sotto il profilo letterale, ma che ha l’obbligo di essere bella, armoniosamente costruita, piacevole per colui che legge o ascolta. La verità è racchiusa nella menzogna della lettera e può riguardare il rapporto fra uomini (verità morale), il rapporto dell’uomo con Dio (verità anagogica). Contrapposta all’allegoria dei poeti c’è l’allegoria dei teologi in cui la verità spirituale si nasconde entro la verità storica esposta, dalla lettera. La grande differenza riguarda dunque la lettera: la realtà storica, il processo storico dell’umanità narrato dai libri sacri è la trama letterale entro cui il teologo va scoprendo la sua verità allegorica; il poeta la scopre invece nella trama letterale delle sue immagini e invenzioni. L’allegoria diviene mezzo espressivo.
La linea interpretativa suggerita da Dante deve considerare la Vita Nova come una confessione detta attraverso aneddoti di realtà storica, mentre il Convivio sarà da considerare una confessione tradotta in aneddoti di realtà spirituale, allegoricamente espressi. Le norme per la partizione del commento prevedono che prima sarà illustrata la lettera e quindi l’allegoria di ciascuna canzone. Dieci capitoli del secondo trattato sono dedicati all’esposizione della lettera 5 dell’allegoria. Così nel terzo trattato. Il primo aveva trattato l’allegoria. La maggior fatica interpretativa deve essere dedicata alla lettera. Il terzo trattato che si può ritenere la matrice filosofica della Commedia e in particolare della terza cantica, tratta l’argomento dell’ordine gerarchico dell’universo legato all’ordine causale e al problema della causalità. Il quarto trattato ha dimensioni doppie rispetto ai due precedenti. La struttura resta intessuta sul numero 15. I trenta capitoli si dividono in due parti: i primi 15 confutano le parti errate e correnti; i secondi 15 presentano e documentano la tesi dell’autore. In ciascun trattato il centro dell’argomentazione si trova nel V capitolo. Nel V capitolo del I trattato Dante imposta la questione del volgare, nel V del II vengono descritte le gerarchie angeliche, nel V del III è descritta la terra e il suo ordinamento in seno all’universo, nel V del IV si tratta di Roma e della provvidenzialità della sua monarchia. Nel capitolo XX del IV trattato, come a dire il V della II parte, si definisce la nobiltà umana come seme messo da Dio nell’anima ben disposta. L’ordine dei quinti capitoli è in qualche modo un’analogia dell’ordine universale dal cielo alla terra, dalla cosmologia celeste alla terrestre, dall’ordine umano collettivamente inteso come monarchia e pace provvidenziale, fino all’individuo e alla sua perfezione di nobiltà. Nella Commedia il gioco strutturale non si baserà sul 5, ma sul 3 e sui suoi multipli.
Fonti del Convivio: Aristotele, San Tommaso, Averroé, San Bernardo di Chiaravalle, San Bonaventura da Bagnoregio, Riccardo di San Vittore, Sant’Agostino, Sant’Anselmo, la Scolastica, Alberto Magno.