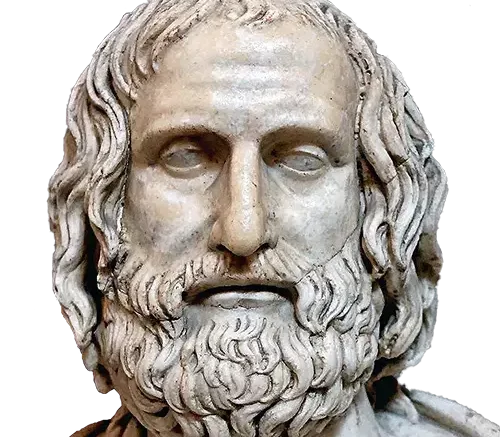Il Protagora è un dialogo platonico di grande rilievo, scritto probabilmente nel IV secolo a.C., che affronta il tema centrale dell’insegnabilità della virtù e della natura del sapere morale e politico. Attraverso un confronto serrato tra Socrate e il sofista Protagora, Platone indaga le possibilità e i limiti della formazione etica e politica, mettendo in luce le tensioni tra filosofia e sofistica, tra conoscenza e potere, e tra virtù come unità o molteplicità.
Contesto e struttura del dialogo.
Il dialogo si svolge in un ambiente privato, durante un incontro tra Socrate, Protagora e altri personaggi ateniesi, tra cui Alcibiade, Callia e Crizia. Socrate, che inizialmente sfugge alle domande sul suo rapporto con Alcibiade, racconta al suo interlocutore anonimo il dialogo avuto con Protagora, in cui si discute soprattutto se la virtù possa essere insegnata come una vera e propria tecnica.
La discussione si sviluppa attraverso un confronto dialettico che alterna momenti di dialogo serrato a lunghi discorsi, con Socrate che insiste per una comunicazione più breve e dialogica (brachilogia), mentre Protagora preferisce un discorso ampio e articolato, tipico della sua arte retorica e della sua funzione di sofista.
Temi principali.
L’insegnabilità della virtù.
Il tema centrale è se la virtù possa essere insegnata come una tecnica, alla stregua delle arti pratiche come la medicina o la musica. Socrate mette in dubbio che esistano veri esperti di virtù, dato che spesso chi è virtuoso non riesce a trasmettere tale virtù ai propri figli, e che tutti gli uomini partecipano alle decisioni politiche senza che vi sia una vera specializzazione o competenza riconosciuta.
Protagora, dal canto suo, sostiene che la virtù è insegnabile e che il suo insegnamento è essenziale per formare buoni cittadini capaci di vivere in armonia nella polis. Egli afferma che la virtù politica è un dono divino concesso da Zeus agli uomini per superare le discordie e garantire la convivenza civile5. Nel suo discorso, Protagora propone anche un mito in cui Zeus distribuisce agli uomini la giustizia e la virtù politica, fondamentali per la sopravvivenza e il progresso umano.
L’unità della virtù.
Un altro nodo fondamentale del dialogo è la questione se la virtù sia un’unità o un insieme di parti distinte. Protagora paragona le diverse virtù (coraggio, temperanza, giustizia, santità) alle parti di un volto, distinte ma coordinate; Socrate invece sostiene che non è possibile che una persona possieda una virtù senza possedere anche le altre, perché esse sono in realtà un’unica realtà morale indivisibile. Questa tesi dell’unità delle virtù sarà poi fondamentale nella filosofia socratica e platonica.
La natura del bene e del male.
Nel dialogo emerge anche una riflessione sul rapporto tra piacere, dolore, bene e male. Socrate e Protagora concordano sul fatto che ciò che sembra piacevole nel momento può portare dolore in seguito, e viceversa, e che dunque il bene e il male vanno valutati in base alle conseguenze a lungo termine. Questa posizione, nota come «tesi edonistica» del Protagora, sottolinea l’importanza della sapienza nel giudicare ciò che è veramente utile o dannoso per l’uomo.
La comunicazione del sapere e il potere.
Il dialogo affronta inoltre il problema della comunicazione e del potere insito nel sapere. Socrate osserva che, a differenza delle altre arti, in politica tutti hanno diritto di parola, come se tutti fossero esperti, il che rende difficile stabilire chi realmente possieda la conoscenza della virtù. Protagora, come sofista, è consapevole che la sua arte è anche una forma di potere e di monopolizzazione dell’attenzione, e che il discorso lungo e monologico serve a consolidare la sua autorità e il suo prestigio.
Significato filosofico.
Il Protagora rappresenta una tappa fondamentale nella filosofia platonica, segnando la transizione dai dialoghi giovanili a quelli più maturi, in cui Platone sviluppa una critica articolata alla sofistica e una riflessione profonda sull’etica e la politica. Il dialogo mette in luce le difficoltà di fondare una scienza morale e politica, ma anche la necessità imprescindibile di educare alla virtù per il bene della città.
La discussione sull’unità della virtù anticipa temi che saranno sviluppati nella Repubblica, mentre il mito di Protagora sottolinea l’importanza della giustizia come fondamento della convivenza sociale. Infine, il dialogo evidenzia la tensione tra sapere come ricerca condivisa e sapere come strumento di potere, un tema ancora attuale nella riflessione filosofica e politica.
In sintesi, il Protagora di Platone è un’opera ricca e complessa che, attraverso il confronto tra Socrate e il sofista Protagora, esplora l’insegnabilità della virtù, la sua natura unitaria, il rapporto tra piacere e bene, e il ruolo del sapere nella politica e nella società, offrendo una riflessione ancora oggi centrale nella filosofia morale e politica.